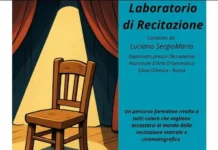Siamo davvero certi che con l’attuale conoscenza scolastica del Latino saremmo in grado, se per un misterioso quanto improbabile corridoio temporale potessimo essere catapultati nella Roma del I sec. a. C., di poter girare per le strade dell’Urbe sostenendo una conversazione? Certamente potremmo essere compresi nelle richieste di base come una pocula di vino in una delle tante tabernae oppure potremmo decodificare una lapide funebre posta lungo una via consolare, saremmo in grado di richiedere del garum per condire gli spiedini di carne o di pesce preparati dall’oste di turno il quale se avessimo consumato, pagando di più, seduti piuttosto che in piedi ci avrebbe servito senza forchetta poiché l’uso ne era ancora sconosciuto. Quindi solo cucchiaio e ciò che oggi ritorna per il fingle food: le dita. Il tutto molto saporito e innaffiato da una pocula di vino senza le solite quattro parti di acqua e una di alcol. Di certo avremmo visto una folla enorme composta per lo più di schiavi, circa un terzo della popolazione libera, ed avremmo udito una gran varietà di lingue che si sarebbero intrecciate; avremmo riconosciuto gli schiavi dal collare che pendeva loro dal collo e da cui si sarebbe potuta desumere la loro misera condizione senza futuro e senza via di fuga infatti in questo caso esso sarebbe servito da autodenuncia recando inciso il nome del padrone cui egli apparteneva con le coordinate della casa- prigione e persino la lauta mancia per chi lo avesse ricondotto all’ovile per la punizione dovuta. Il linguaggio popolare non ci avrebbe permesso facile comprensione poiché era totalmente lontano da quello cui siamo abituati attraverso gli studi però molti vocaboli simili a quelli contemporanei ci avrebbero stupiti. Totalmente differente la frequentazione con le case più ricche in cui la lingua ufficiale era il greco e senza la conoscenza di questo la conversazione sarebbe languita fino a divenir nulla. Infatti saper conversare in greco era una conditio troppo importante e concedeva di poter far parte dell’élite tant’è che tale lingua veniva impartita fin da giovanissimi e per uno schiavo istruito la cifra da pagare era davvero elevata. Né spostandoci in campagna l’uso del sermo rusticus ci avrebbe salvato. Era questo un latino campagnolo con inflessioni dialettali e vocaboli legati al ciclo della natura, sovente ancora arcaici quindi lontani da quelli eleganti usati da Orazio o Tibullo. Se per ventura ci fossimo addentrati in un accampamento militare, ecco il sermo militaris usato dai soldati reclutati nelle varie provincie in cui il latino imposto si era coniugato con le lingue locali dando vita ad un vocabolario sovente bastardo. Alle frontiere è evidente che il latino avesse subito trasformazioni notevoli dovute al matrimonio con il preesistente che poi, come ben si sa, ritornò in vita dando luogo alle lingue volgari. Il parallelismo con i giorni d’oggi ci conduce ai medesimi risultati: conoscere scolasticamente la lingua inglese( ha soppiantato il latino nella comunicazione globale)non ci rende totalmente autonomi andando a Londra a meno che un prolungato soggiorno nella città non ci faccia acquisire la lingua quotidiana che non sempre si coniuga con quella dello studio classico.
Siamo davvero certi che con l’attuale conoscenza scolastica del Latino saremmo in grado, se per un misterioso quanto improbabile corridoio temporale potessimo essere catapultati nella Roma del I sec. a. C., di poter girare per le strade dell’Urbe sostenendo una conversazione? Certamente potremmo essere compresi nelle richieste di base come una pocula di vino in una delle tante tabernae oppure potremmo decodificare una lapide funebre posta lungo una via consolare, saremmo in grado di richiedere del garum per condire gli spiedini di carne o di pesce preparati dall’oste di turno il quale se avessimo consumato, pagando di più, seduti piuttosto che in piedi ci avrebbe servito senza forchetta poiché l’uso ne era ancora sconosciuto. Quindi solo cucchiaio e ciò che oggi ritorna per il fingle food: le dita. Il tutto molto saporito e innaffiato da una pocula di vino senza le solite quattro parti di acqua e una di alcol. Di certo avremmo visto una folla enorme composta per lo più di schiavi, circa un terzo della popolazione libera, ed avremmo udito una gran varietà di lingue che si sarebbero intrecciate; avremmo riconosciuto gli schiavi dal collare che pendeva loro dal collo e da cui si sarebbe potuta desumere la loro misera condizione senza futuro e senza via di fuga infatti in questo caso esso sarebbe servito da autodenuncia recando inciso il nome del padrone cui egli apparteneva con le coordinate della casa- prigione e persino la lauta mancia per chi lo avesse ricondotto all’ovile per la punizione dovuta. Il linguaggio popolare non ci avrebbe permesso facile comprensione poiché era totalmente lontano da quello cui siamo abituati attraverso gli studi però molti vocaboli simili a quelli contemporanei ci avrebbero stupiti. Totalmente differente la frequentazione con le case più ricche in cui la lingua ufficiale era il greco e senza la conoscenza di questo la conversazione sarebbe languita fino a divenir nulla. Infatti saper conversare in greco era una conditio troppo importante e concedeva di poter far parte dell’élite tant’è che tale lingua veniva impartita fin da giovanissimi e per uno schiavo istruito la cifra da pagare era davvero elevata. Né spostandoci in campagna l’uso del sermo rusticus ci avrebbe salvato. Era questo un latino campagnolo con inflessioni dialettali e vocaboli legati al ciclo della natura, sovente ancora arcaici quindi lontani da quelli eleganti usati da Orazio o Tibullo. Se per ventura ci fossimo addentrati in un accampamento militare, ecco il sermo militaris usato dai soldati reclutati nelle varie provincie in cui il latino imposto si era coniugato con le lingue locali dando vita ad un vocabolario sovente bastardo. Alle frontiere è evidente che il latino avesse subito trasformazioni notevoli dovute al matrimonio con il preesistente che poi, come ben si sa, ritornò in vita dando luogo alle lingue volgari. Il parallelismo con i giorni d’oggi ci conduce ai medesimi risultati: conoscere scolasticamente la lingua inglese( ha soppiantato il latino nella comunicazione globale)non ci rende totalmente autonomi andando a Londra a meno che un prolungato soggiorno nella città non ci faccia acquisire la lingua quotidiana che non sempre si coniuga con quella dello studio classico.
Maddalena Rispoli